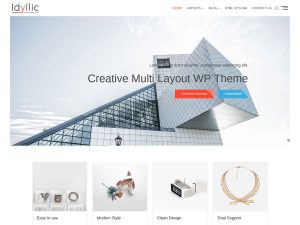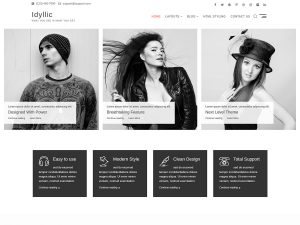Il DCM nel DSM-V fa parte dei disordini motori e include i disturbi grosso motori, dal camminare al muoversi con agilità e con destrezza, sino all’equilibrio, ma anche disordini della motricità fine, come la scrittura e altre azioni manuali.
Nell’ultima edizione del Manuale diagnostico e statistico
dei disordini mentali, uscita negli Stati Uniti nel 2013 e in Italia nel 2014, si legge che <>(APA, 2014).I criteri diagnostici con cui vengono individuati i soggetti con DCD nel DSM-5 sono:
L’acquisizione e l’esecuzione di attività motorie coordinate risultano notevolmente inferiori rispetto a quanto atteso, considerate l’età cronologica dell’individuo e le opportunità che esso ha avuto di apprendere e utilizzare tali abilità. Le difficoltà si manifestano con goffaggine (per esempio cadere o sbattere contro oggetti), così come con lentezza e imprecisione nello svolgimento delle attività motorie (per esempio afferrare un oggetto, usare forbici o posate, scrivere a mano, guidare la bicicletta o partecipare ad attività sportive).
Il deficit delle abilità motorie indicato nel criterio 1 interferisce in modo significativo e persistente con le attività della vita quotidiana adeguate all’età cronologica (per esempio nella cura e nel mantenimento di sé) e ha un impatto sulla produttività scolastica, sulle attività pre-professionali e professionali, sul tempo libero e il gioco.
L’esordio dei sintomi avviene nel primo periodo dello sviluppo.
I deficit delle abilità motorie non sono meglio spiegati da disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo) o da deficit visivo e non sono attribuibili a una condizione neurologica che influenza il movimento (come ad esempio: paralisi cerebrale, distrofia muscolare o malattie neurodegenerative).
Il criterio A afferma che la manifestazione di deficit nelle abilità motorie, rispetto ai livelli attesi per età cronologica, è segno di disprassia: può essere presente un ritardo in alcune abilità motorie e anche quando queste vengono raggiunte, l’esecuzione del movimento può essere goffa, lenta, poco precisa.
La disprassia è diagnosticata inoltre solamente se il deterioramento delle capacità motorie interferisce significativamente con le prestazioni, o la partecipazione, dell’individuo alle attività quotidiane: quali vestirsi, mangiare con utensili adatti all’età, utilizzare strumenti specifici in classe, partecipare a giochi (criterio B). Spesso si riscontrano inoltre notevoli difficoltà nelle competenze manuali come le componenti motorie della scrittura.
Seppur il Criterio C affermi che l’insorgenza dei sintomi deve verificarsi nel periodo di sviluppo iniziale, la disprassia è solitamente diagnosticata dai 5 anni in poi; in quanto le abilità motorie non si manifestano in tutti alla stessa età: vi è un ampio range nel quale si possono presentare.
Il Criterio D specifica che la diagnosi di disprassia non deve essere associata a disabilità visiva o attribuibile ad una condizione neuropatologica, per questo motivo nella valutazione diagnostica deve essere incluso anche l’esame della funzione visiva e quello neurologico. Il QI deve essere maggiore di 85 e il QS delle abilità motorie non deve discostarsi di più di 2 deviazioni standard da quello medio per età cronologica.
La diagnosi di DCD è un insieme di dati che vengono raccolti dal neuropsichiatra infantile, con l’aiuto e la partecipazione delle persone presenti nella vita del bambino, infatti viene raccolta la storia clinica del bambino (decorso della gravidanza, anamnesi), esame fisico del bambino.
Si tratta quindi di una valutazione molto ampia dell’ambito motorio e dei movimenti, che tiene presente diverse e importanti componenti motorie e di tipo cognitivo sottostanti l’organizzazione e l’esecuzione del movimento.
I bambini con disturbo di coordinazione motoria mostrano comportamenti motori variabili in diversi tipi di compiti e sono più vulnerabili alle perturbazioni del movimento (Zoia, 2004). Per questo motivo, possono essere riscontrati deficit differenti nei processi che regolano la funzione motoria.
Ad esempio si potrebbe avere un disturbo che interessa l’utilizzo di un gesto volontario per servirsi appropriatamente di un oggetto (gesto transitivo), indicato come disprassia evolutiva (un deficit a livello di pianificazione o recupero di un piano motorio d’azione), o un deficit a carico delle competenze grafo-motorie che determinerebbe un disturbo della scrittura (disgrafia), intesa come incapacità di realizzare i movimenti necessari alla riproduzione di grafemi (compromessa in questo caso sarebbe la componente di memoria senso-motoria, questa mette in relazione la percezione sensoriale fine della mano con informazioni visuo-spaziali), o si potrebbe avere un deficit per quanto riguarda l’integrazione dell’informazione percettiva con il movimento, ma anche con altre componenti di tipo attentivo.
L’ICD 10 (F82 – Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria), citato nel DSM-5, afferma che “la principale caratteristica di questo disturbo è una grave compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria, che non è solamente spiegabile in termini di ritardo intellettivo generale o di una patologia neurologica congenita o acquisita” e che “È abituale che l’impaccio motorio si associ a una certa compromissione della prestazione nei compiti cognitivi visuo-spaziali”.
La disprassia è, quindi, caratterizzata dall’incapacità di compiere movimenti volontari e coordinati in modo sequenziale tra loro, in funzione di uno scopo. La sequenza motoria risulta alterata nei requisiti spaziali e temporali e spesso associata a movimenti non richiesti con la conseguenza che l’attività motoria, anche se eseguita con rapidità ed in modo apparentemente abile, può essere del tutto inefficace e scorretta. Questa è una condizione in cui, in assenza di disordini neurologici elementari motori e sensitivi, si manifestano difficoltà o incapacità nell’eseguire in maniera corretta movimenti volontari aventi significato (gesti) o privi di specifico significato; è un disordine di pianificazione (strategie del movimento) e programmazione (organizzazione sequenza) dell’attività motoria complessa non dovuta a paresi, atassia, distonia, discinesia, perseverazione.
Segni e sintomi
La prevalenza dello sviluppo dei disordini di coordinazione motoria in bambini tra i 5 e gli 11 anni è del 5% -6 % (in bambini di 7 anni, l’1.8% ha diagnosi severa di disturbo di coordinazione motoria e il 3% di probabile DCD). I maschi sono più colpiti delle donne, con rapporto uomo/donna di 2:1 e 7:1 (APA, 2014).
Si ritiene che l’eziologia del disturbo in età evolutiva sia di tipo multifattoriale e i fattoti di rischio implicati sembrano essere l’ipossia, il basso peso alla nascita, la malnutrizione perinatale e un più lento e/o irregolare sviluppo delle abilità psicomotorie. (Harold et al.,2001).
Dalle ricerche emerge quanto sia difficile che il disturbo si presenti in modo isolato, è stata evidenziata un ‘alta percentuale di casi in cui è associato ad altri ritardi dello sviluppo (Visser, 2003; Mazagù,2002; Kaplan et al.,2001). In particolare, è stata osservata la frequente compresenza tra il DCM ed il disturbo da deficit d’attenzione ed iperattività (Piek et al.,2006; Pitcher et al., 2003).
È evidente che le caratteristiche del bambino con DCM possono manifestarsi in maniera molto diversa a seconda del profilo di funzionamento (Zoia,2004). Per questo motivo possono essere riscontrati deficit differenti nei processi che regolano la funzione motoria. A seconda delle componenti compromesse, la letteratura utilizza termini differenti per identificare il problema. Un disturbo che interessa l’utilizzo di un gesto volontario per servirsi di un oggetto viene indicato come disprassia evolutiva. Diversamente invece, un deficit a carico delle competenze grafo-motorie determinerebbe un disturbo della scrittura intesa come incapacità di realizzare i movimenti necessari alla riproduzione di grafemi. In questo caso, apparirebbe compromessa la componente di memoria senso-motoria, ovvero una sorte di mappa che mette in relazione la percezione sensoriale del movimento fine della mano con le informazioni visuo-spaziali.
Inoltre il deficit può interessare un l’integrazione dell’informazione percettiva con il movimento, ma anche con altre componenti di tipo attentivo, necessarie ai fini del controllo motorio.
A differenza di quanto si credeva in passato circa la benignità di questa condizione infantile, studi longitudinali hanno dimostrato che la presenza di DCM può protrarsi fino all’adolescenza e all’età adulta (Cousins et al.,2003; Losse et al.,1991) comportando gravi conseguenze nel lungo termine sul piano sociale, emotivo, scolastico-accademico e psichiatrico (Sigurdsson et al.,2002; Rasmussen and Gillberg,2000; Van O set al.1997).