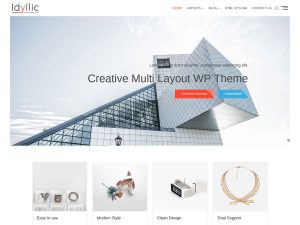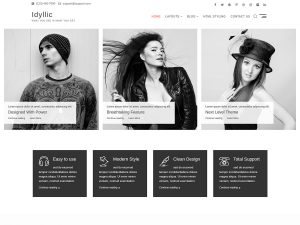I disturbi di linguaggio colpiscono circa il 6-8% della popolazione mondiale e, secondo la classificazione dell’ICD-10 (International Classification of Diseases – 10th edition, redatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), si distinguono in:
• Disturbo specifico dell’articolazione e dell’eloquio
(ritardo nell’acquisizione dell’abilità di produzione dei suoni verbali)
• Disturbo del linguaggio espressivo (adeguato livello di comprensione di linguaggio a fronte di un livello espressivo al di sotto della media attesa per l’età cronologica)
• Disturbo della comprensione del linguaggio (livello di comprensione del linguaggio non adeguato per l’età cronologica).
Disturbo dell’articolazione dell’eloquio
• E’ compromessa l’articolazione del suono. Il problema è prevalentemente motorio.
• E’ secondario non è primitivo. Va in diagnosi differenziale con il disturbo fonologico.
• Il bambino disartrico può avere una paralisi cerebrale o un danno cerebellare.
• La frase può essere discretamente strutturata o addirittura corretta sul versante lessicale, morfo-sintattico e pragmatico, ma i suoni non vengono correttamente articolati per un problema motorio, per cui il messaggio può risultare difficilmente comprensibile.
Secondo il DSM V (2013):
• Disturbo del linguaggio
• Disturbo fonetico-fonologico
• Disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia (balbuzie)
• Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica)
• Disturbo della comunicazione senza specificazione
Disturbo di linguaggio (DSM-5)
A. Difficoltà persistenti nell’acquisizione e nell’uso di diverse modalità di linguaggio (parlato, scritto, gestuale o di altro tipo) dovute a deficit della comprensione o della produzione che comprendono i seguenti elementi: 1.Lessico ridotto (conoscenza ed uso delle parole) 2.Limitata strutturazione delle frasi 3.Compromissione delle capacità discorsive (di connettere le frasi tra loro per sostenere una conversazione) B. Le capacità di linguaggio sono al di sotto da quelle attese per l’età in maniera significativa e quantificabile, portando a limitazioni funzionali dell’efficacia della comunicazione, della partecipazione sociale, dei risultati scolastici o professionali
C. L’esordio dei sintomi avviene nel periodo precoce dello sviluppo
D. Le difficoltà non sono attribuibili a compromissione dell’udito o ad altra compromissione sensoriale, a disfunzione motorie o altre condizioni mediche e non sono spiegabili da disabilità intellettiva o ritardo globale di sviluppo
Disturbo Fonetico – fonologico (DSM-5)
• Il bambino ha delle discrete capacità di comprensione, ma presenta difficoltà riguardo all’uso dei suoni (es. tole invece di “sole”). I suoni che compongono le parole possono essere omessi (es. tada per “strada”), sostituiti o distorti. Nella maggior parte dei casi le difficoltà riguardano i suoni che vengono imparati più tardi (“r”, “v”); nei casi più gravi sono interessate tutte le consonanti comprese le vocali e l’eloquio risulta incomprensibile.
• L’alterazione causa limitazioni dell’efficacia della comunicazione che interferiscono con la partecipazione sociale, il funzionamento scolastico o lavorativo
• L’esordio avviene in un periodo precoce dello sviluppo
• Le difficoltà non sono dovute a deficit sensoriali o a patologie organiche (PCI, sordità o ipoacusia, palatoschisi)
Disturbo pragmatico di linguaggio
• Difficoltà nel mantenere i turni e l’argomento del discorso
• Comprensione altamente letterale: il sarcasmo, l’uso metaforico del linguaggio o comunicazione gestuale possono essere equivocati
• Difficoltà di comprensione orale e scritta
• Scarsa coordinazione dei registri di comunicazione verbale e non verbale
• Difficoltà nel cambiare il contenuto di un enunciato in accordo a ciò che la situazione richiede
• Difficoltà nel fornire precise informazioni a richieste specifiche
Balbuzie
• La balbuzie si caratterizza per un’alterazione della fluenza e cadenza dell’eloquio, inappropriata per l’età e con ripetizioni o prolungamento delle lettere o delle sillabe (aaaadesso) iniziali della parola.
• L’alterazione causa ansia nel parlare o limitazioni dell’efficacia di comunicazione, della partecipazione sociale, del rendimento scolastico o lavorativo.
• Esordio tra 5 e 10 anni. M:F=3:1.
• Diagnosi dopo i 3 anni.
• Si può associare a tic.
• Il bambino rallenta l’eloquio, oppure riduce la produzione. Nei casi estremi evita di parlare.
• Lo stress emotivo peggiora il sintomo e in genere periodi di disagio emotivo lo fanno comparire.
• Può risolversi oppure può durare molto tempo, fino a tutta la vita. Circa l’80% dei casi va incontro a remissione spontanea, prima dei 16 anni.
Diagnosi
Importante valutare le capacità imitative e di gioco simbolico nei bambini con sospetto disturbo di linguaggio. Valutare le abilità prassiche e di coordinazione motoria. Valutazione cognitiva con test appropriati.
Indici predittivi di disturbo di linguaggio (Volterra e Bates, 1995; Bates, 2002)
• Assenza della lallazione, prima vocalica poi consonantica dai 5 ai 10 mesi;
• Assenza di utilizzazione dei gesti, sia deittici che referenziali, a 12-14 mesi;
• Mancata acquisizione di schemi d’azione con oggetti a 12 mesi;
• Vocabolario ridotto (meno di 20 parole a 18 mesi e meno di 50 parole a 24 mesi);
• Assenza o ridotta presenza di gioco simbolico tra i 24-30 mesi;
• Ridotta presenza di sequenza di gioco simbolico tra i 30 e i 40 mesi;
• Ritardo nella comprensione di ordini non contestuali e che implicano una decodifica linguistica a 24-30 mesi.
Secondo il DSM V (2013):
• Disturbo del linguaggio
• Disturbo fonetico-fonologico
• Disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia (balbuzie)
• Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica)
• Disturbo della comunicazione senza specificazione
Sebbene si sia cercato a lungo il gene responsabile dei DSL, gli studiosi sono giunti alla conclusione che, nella maggior parte dei bambini, questi disturbi hanno origini complesse, generate da molti di fattori ambientali e genetici che interagiscono tra loro.
Quindi è impossibile identificare un’unica causa per questo genere di disturbi.
Ad oggi i disturbi del linguaggio sono considerati un insieme di sintomi. I bambini con disturbi specifici di linguaggio presentano difficoltà, di vario grado, nella comprensione, produzione e uso del linguaggio.
L’evoluzione di questi sintomi dipende dalla gravità e dalla persistenza del disturbo linguistico.
Normalmente i bambini affetti da DSL ottengono una diagnosi attorno ai tre anni di età, con l’ingresso alla scuola materna. Tuttavia la fase più delicata di insorgenza di questi disturbi è attorno ai due anni.
VALUTAZIONE
La valutazione diagnostica prevede il coinvolgimento di diverse figure specialistiche: neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, psicologo dell’età evolutiva, logopedista e terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva.
Al termine dell’inquadramento diagnostico viene stilato un profilo funzionale volto
La diagnosi viene definita per esclusione rispetto alle condizioni sopra elencate.
Per determinare se un bambino è affetto da DSL è importante valutare se l’intelligenza del bambino risulta normale.
Inoltre i disturbi del linguaggio non devono essere causati da altre patologie, né da deficit sensoriali: un bambino sordo ha più difficoltà a formulare le parole correttamente senza essere necessariamente affetto da DSL.
Non devono poi essere presenti importanti carenze socio-ambientali. Un bambino cresciuto in un contesto privo di interazioni sociali può avere difficoltà a parlare, senza essere necessariamente affetto da disturbi linguistici.
Per effettuare diagnosi di DSL va utilizzato un doppio parametro. Bisogna che il QI sia nella norma e che il punteggio di valutazione delle competenze linguistiche sia sotto la media.
È importante infine valutare alcuni indici predittivi non linguistici. Un esempio è l’assenza dei comportamenti deittici, il più comune tra i quali è il gesto di indicare.
Tutti queste valutazioni non possono essere eseguite in contesti familiari ma devono essere fatte da professionisti.
Fonti
Letizia Sabbadini, Disturbi specifici del linguaggio in Disturbi specifici del linguaggio, disprassie e funzioni esecutive. Metodologie Riabilitative in Logopedia, Milano, Springer (2013).
Bishop D.V. (2006), What causes specific language impairment in children?, Current Directions in Psychological Science, 5, pp. 217-221.
Federazione Logopedisti Italiani: www.fli.it
Intendenza Scolastica, Provincia di Bolzano: www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/ICD10_Linguaggio.pdf